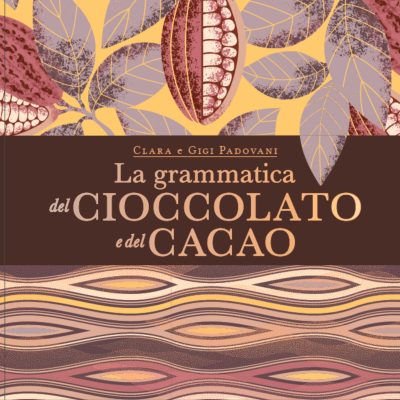Di Gigi Padovani
Castelvecchi 1999
La Nutella non è una semplice crema da spalmare ma rappresenta una fetta della nostra vita e del nostro immaginario. Gigi Padovani racconta la storia e la mitologia di questo universo semiotico (e alimentare) racchiuso in un barattolo. Adottata dagli ex-sessantottini ma anche portabandiera ufficiale del nostro Paese (al pari della pasta o dell’alta modo), la Nutella è riuscita a ‘tagliare’ trasversalmente le ideologie ma soprattutto a riconcialiare una cultura profondamente cattolica come quella italiana con il puro piacere. L’ascesa della Casa madre (passata in pochi anni da laboratorio artigianale a holding multinazionale), le campagne pubblicitarie, la ‘dipendenza’ dei Vip, i significati sociologici e il valore mediale della parola Nutella hanno fatto di questo prodotto una ‘metafora del desiderio’. Un mix di marketing e genio artigianale (uniti dall’ineffabile quid che fonda ogni merce di culto) si trasforma così in un singolare strumento per comprendere significati e cambiamenti del tempo che vivviamo.
Indice del libro
PARTE PRIMA – LA STORIA
Gli antenati della Nutella – La fabbrica di cioccolato
PARTE SECONDA- IL MITO
Una merce di culto – La generazione Jo Condor – Il barattolo è il messaggio – Filologia di una crema classica – La passione dei Vip – Internut – La modica quantità – L’amore al tempo della Nutella
PARTE TERZA – L’AZIENDA
Dalla bottega alla holding – Due volte sotto l’acqua – La dinastia della Nutella
Incipit del libro
Nella casa sulla collina il silenzio avvolge tutte le stanze. Il fruscio dell’Ibm mi tiene legato alla tastiera, nel bagliore della lampada Tizio ormai rovente. Ho finito di scrivere. Tutto il lavoro ora è condensato in tre dischetti neri, pronti ad essere spediti al mio editore. Mesi passati a rubare tempo al sonno, a indagare archivi editoriali, a navigare in Internet, a fare interviste, a scartabellare negli uffici anagrafe e nei registri delle parrocchie. E poi leggere, riassumere, catalogare, scrivere.
Il computer ronza più sornione del solito. L’hard disk dentro la colonna gira tranquillo. Memorizzando con il mouse sul pad della Tucano che riproduce una fetta di pane spalmata di crema marrone, dopo il clic sento lo sfrigolio dentro la torre a fianco del video, come quando un cacciavite passa veloce su un pettine.
Ultimi gemiti della macchina. Dal salvaschermo Nanni Moretti mi guarda, in bianco e nero, con il barattolone a fianco e una fetta di pane in bocca, a torso nudo, capelli lunghi e sguardo estatico. Ho trovato l’immagine nel sito di un fanatico morettiano e naturalmente l’ho salvata e scaricata dalla rete. Mi ha accompagnato in tante notti di lavoro: psicologia, filologia, marketing, sociologia, storia.
Ciao, Nanni. Abbandono Windows. Apro la finestra “chiudi sessione”. Clicco su “arresta il sistema”. Musichetta. Collasso. Si spegne tutto e dalla colonna emerge un suono di frizione che si arresta, come la dinamo della bicicletta. E un piccolo, impercettibile “flop”. E’ diverso dallo sfarfallare della televisione che si spegne. Qui è un mondo che si chiude, quando stacco l’Ibm.
Fa caldo. La Tizio nera scalda. La sedia in pelle nera anche. La fratina in noce scuro restituisce il calore del video e della lampada. Penso: bisogna aprire le finestre. Cambiare un po’ l’aria.
Scendo le scale e mi fiondo in cucina. Lassù, nell’armadietto sopra l’acquaio, nel punto più alto del terzo ripiano, quasi inaccessibile, dove il nostro architetto superfigo ha stabilito la “zona contenimento”, come la chiamava lui, c’è qualcosa che mi aspetta. E’ nascosto dietro a un barattolo di tè e a una scatola di biscotti. No, anzi, c’è pure un vasetto di uva passa, quella da mettere dentro le torte. Ma Lei c’è. Me l’ha regalata una collega quando ha saputo che avrei scritto questo libro. Me l’ha spedita con Dhl da Milano, in una busta di carta marrone con dentro i bolli in plastica per gli oggetti preziosi. Le ho detto: “Grazie, la apro soltanto quando ho finito”.
Adesso posso farlo. Afferro il barattolo di vetro. Lo soppeso. E’ pieno. Bene, mia figlia Alice forse ha avuto paura di ritrovarsi con una esplosione di brufoli e l’ha lasciato al suo posto. L’ultima volta che mi era venuta una voglia notturna, ore tre della mattina dopo una “lunga” passata al giornale, avevo ritrovato semi-vuoto il contenitore della passione. Lo spazzolamento era stato abilmente camuffato, lasciando un velo marrone sulle pareti. Tra l’invitante etichetta, sulla quale campeggiano fetta di pane spalmata di crema, coltello a spatola, bicchiere di latte e due nocciole, e il tappo bianco zigrinato c’è una piccola feritoia: risultava ancora marrone, senza contaminazioni. All’interno invece il vasetto pareva una voragine dopo un temporale a Napoli: un pozzo senza fondo, con le pareti appena sporcate da un velo di prodotto scuro. Così quella volta avevo dovuto rinunciare: in casa se ne sarebbero accorti tutti.
Ma stavolta è diverso. Stavolta ho diritto ad affondare il cucchiaino. Niente coltello, niente spatola. Scucchiaiamento puro, libidine totale, consolazione assoluta. Di notte, nel silenzio, clandestinamente. Come si conviene al consumo di ogni genere voluttuario. Oscar Wilde ha scritto che le cose buone o fanno male o sono proibite. Questa è una eccezione, meglio approfittarne.
Il barattolo è pieno. Un classico 400 grammi. Constato girando la ghiera del coperchio che è ancora illibato. Il massimo. Procedo.
Roteo la plastica bianca con un movimento di 360 gradi, lento, consapevole. Poi avverto come un intoppo. Sono arrivato al punto di non ritorno. Se lo supero, la soglia etica della responsabilità individuale mi dice che dovrò ammettere l’apertura del vasetto. Un’operazione sicuramente piacevole, per chi la compie. Ma l’indomani bisognerà confessare, quando mi verrà domandato: chi l’ha cominciato?
Ebbene sì. Io. Me lo sono meritato.
Ultimo sforzo, e dallo strappo della carta capisco che il dado è tratto. Ma il vero ostacolo è ancora da superare. E’ quel velo in multistrato dorato e puntinato simil-Domopak che ricopre l’imboccatura tonda del barattolo. Avete notato? La chiusura è tonda, ma il corpo del contenitore in vetro è elissoidale, con la base a forma di rettangolo dai lati smussati. Si prende meglio in mano, si allinea più comodamente sul banco del supermercato.
Lo strappo della protezione in carta è il momento iniziale del rito. Un movimento lento, anche per non fare rumore, ma deciso. E subito arriva l’effluvio. Sentori di nocciola, persistenti. Di olio, di vaniglia e di zucchero. Poi, quasi di soppiatto, entra nel naso il cacao.
La bocca si riempie di saliva, il cervello già immagina l’impatto della lingua con la crema, una poltiglia molle che invade il palato, ai lati delle gengive, sopra i denti.
Cucchiaino o dito?
Meglio il cucchiaino, ne viene di più, e si può continuare a lungo senza troppi problemi. Con il dito c’è il rischio che vada a finire sotto le unghie, che poi qualcuno se ne accorga o che si sporchino le lenzuola quando si torna a letto.
Il cucchiaino affonda morbido. La superficie violata si increspa, lascia trasparire un piccolo collasso della pellicola superiore al lago di crema, poi si adatta alla forma dell’acciaio che la penetra senza più esitazioni.
Sollevo il cucchiaino e sotto di esso si forma qualche filamento lungo che non vuole staccarsi. Bisogna fare attenzione, evitare la macchia sulla canottiera, una tragedia per molte generazioni.
Occorre girare velocemente la posata su se stessa di 360 gradi, in modo da raccogliere per bene tutto il nettare. Quindi avvicinarla alle labbra. Il profumo arriva dritto nel cervello. Sono inebriato.
La prima cucchiaiata è profonda, peccaminosa, ma rapida. La crema si va subito a impastare sulle labbra, poi sale sulla lingua, finisce in fondo al palato e si infila tra i denti. Mi fermo, estasiato. Inghiotto rapidamente e lascio lavorare le papille gustative. Ora posso dedicarmi alle labbra, dove è rimasta una consistente quantità di crema marrone.
Ma non riesco a fermarmi. Una cucchiaiata non basta. E’ soltanto l’inizio. La bocca richiede altro cacao, altre nocciole, altro zucchero. La sensazione di piacere comincia a circolare in tutto il corpo.
Non mi stanco, anzi non posso smettere. Però dovrei farlo. Devo riflettere, sentire il sapore, come mi hanno insegnato ai corsi di degustazione. Entra molle ma pastosa, si scioglie in bocca, la sento liquida nello stomaco. E solletica il palato allappandolo con soave prepotenza. Non posso mangiare nient’altro. Neppure un grissino o un pezzo di pane. Forse potrei bere un po’ d’acqua.
Ecco arrivare il retrogusto. Nocciole, vaniglia, cacao.
Ma quell’altra sensazione cos’è? Una cucina Anni Sessanta con il tavolo in fòrmica giallino e le sedie dalle gambe tubolari d’acciaio inox. Piedini di gomma. Sto per andare a scuola, al liceo. Un barattolo aperto sul tavolo. Una tazza di latte bianco. Una fetta di pane. Nel mangiadischi una canzone di Patty Pravo, in anticamera i libri di latino e greco tenuti insieme da una cinghia in gomma verde tutta istoriata. Nell’armadio un eschimo verde, le Clark’s ai piedi. Avevo già la barba. Trentadue anni fa.
L’onda del ricordo mi assale per un attimo. Forse sto esagerando, ma affondo di nuovo il cucchiaino. Ora arriva anche il retrogusto leggermente sapido. Bisogna vincerlo con un po’ d’acqua. Vado a cercare un Cd con la Ragazza del Piper. Che mondo sarebbe senza la Nutella?